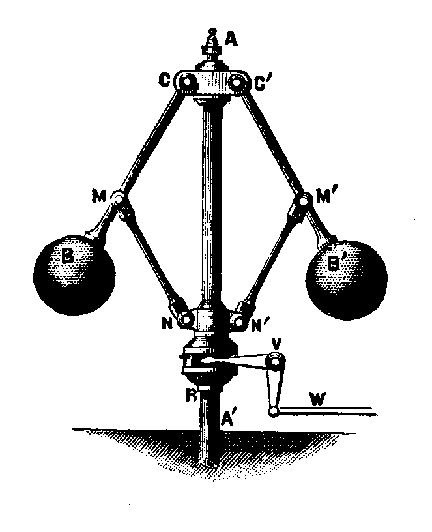
lunedì 2 gennaio 2012
DISAGIO GAY
Partiamo
da un presupposto che è ampiamente e oggettivamente documentato: la
vita di un ragazzo gay presenta spesso motivi di stress che non esistono
nella vita di coetanei etero o che esistono ma in modo meno
problematico. Solo per fare alcuni esempi, la sessualità per un ragazzo
gay è spesso un tabù vissuto come trasgressione e con sensi di colpa,
l’accoglienza nel gruppo dei pari evidenzia che il confronto è limitato e
ha spesso il sapore di una più o meno marcata emarginazione, il
rapporto con la religione è complesso e spesso contraddittorio e le
pressioni in direzione etero da parte della famiglia rappresentano
parecchie volte condizionamenti molto difficili da superare. Si
comprende facilmente quindi perché i ragazzi gay presentino delle forme
di fragilità psicologica che sono meno comuni tra i coetanei etero. In
buona sostanza esistono serie motivazioni oggettive alla base del
disagio dei ragazzi gay. Questo post mira a mettere in evidenza alcuni
meccanismi psichici che spesso condizionano i ragazzi gay e li espongono
al rischio di marginalità e di atteggiamenti depressivi. Basta scorrere
l’indice del Forum di Progetto Gay per notare come il maggior numero di
post si concentra proprio sulla sezione “Disagio gay” e su quella
relativa al “Coming out”, tipico motivo di disagio per i gay.
Come
è ovvio il panorama del disagio gay è quanto mai articolato e complesso
in relazione alle condizioni ambientali dei singoli e alla storia
individuale ma ci sono elementi ricorrenti che possono essere presi
utilmente in considerazione.
LO STAR BENE CON SE STESSI
Mi
capita spesso di vedere ragazzi che sono alla spasmodica ricerca di un
rapporto affettivo forte dal quale sperano di ottenere la soluzione di
tutti i loro problemi, ma la vita di coppia richiede come presupposto lo
star bene con se stessi, condizione senza la quale si costruisce su
basi molto fragili una serie, talvolta assai estesa, di attese poco
realistiche. Che cosa significa stare bene con sé stessi? Significa
prima di tutto mantenere un equilibrio interno complessivo che non
polarizzi in modo radicale tutta la vita affettiva e mentale di una
persona su una sola questione, per quanto importante essa possa essere.
Così come una dieta sana è caratterizzata da un equilibrio tra i vari
nutrienti, lo star bene con se stessi comporta l’armonia di vari
elementi “tutti essenziali” al raggiungimento dell’equilibrio
complessivo. In questo senso va sottolineato che l’autostima dipende
certamente e in modo molto significativo dal successo negli studi e nel
lavoro e che l’abbandono degli studi, il continuo rinvio
nell’affrontarli seriamente, o la perdita del lavoro possono essere
causa di fortissimo stress al quale si reagisce spesso tramite un
meccanismo di compensazione, ossia concentrando tutta la propria
attenzione su un oggetto diverso che molto frequentemente è la vita
affettiva, che viene così caricata di attese e finisce per fornire una
auto-giustificazione del lasciarsi andare. Il vero rischio dei ragazzi
gay non è rappresentato da una deriva sessuale della vita affettiva,
cosa peraltro piuttosto rara, ma dal lasciarsi andare, dal farsi portate
dalla corrente nella convinzione che “tanto” non ci si può fare nulla.
In realtà è vero esattamente il contrario, il futuro è nelle nostre mani
e, da qualsiasi condizione si parta, la possibilità di migliorarlo
esiste certamente anche se richiede uno sforzo serio di volontà.
Sottolineo che la volontà non è un sentimento astratto, ma ha un senso
quando si traduce in scelte concrete cioè in pratica nel destinare il
proprio tempo ad attività produttive di risultati. Vedo ragazzi che, di
fonte a difficoltà nello studio o nel trovare lavoro, difficoltà
quest’ultima particolarmente seria in periodi di crisi economica come
quello che stiamo vivendo, si lasciano vincere da atteggiamenti passivi
e dall’idea di un destino ingovernabile contro il quale nulla può la
volontà individuale. Affermazioni come: “Se non avrò un ragazzo accanto a
me non avrò mai la serenità per mettermi a studiare seriamente”, oppure
come “Tanto nella vita non combinerò mai nulla” sono due modi tipici
per abbandonarsi alla corrente. L’abulia, cioè la mancanza di volontà è
un segno di sofferenza individuale molto significativo, ne deriva la
mancanza di una progettualità rivolta al futuro e la sensazione
percepita di essere portati dalla corrente e, gradualmente, partendo da
qui, si scivola verso atteggiamenti depressi. In un equilibrio psichico
complessivo l’autostima dipende fortemente da elementi legati alla
volontà oltre che all’affettività e la volontà va esercitata per gradi,
nel concreto, nel quotidiano, con progetti a breve termine e non con
discorsi astratti. Per fare ripartire il meccanismo degli studi bisogna
andare a lezione tutti i giorni, studiare tutti i giorni per ore e fare
gli esami, solo questo lavoro concreto e oggettivamente pesante ha un
senso effettivo nella ricostruzione dell’autostima. Qui va chiarito che
vanno affrontati risolutamente quei problemi che possono oggettivamente
essere risolti con un impegno di volontà “individuale”, questo significa
che non ha molto senso cercare di affrontare pervicacemente problemi la
cui soluzione dipende dal rapporto con altre persone, l’esempio tipico è
il coming out, e in particolare il coming out familiare, sul quale
spesso si concentra l’attenzione di molti ragazzi. Riflettere sul coming
out familiare e eventualmente realizzarlo quando le condizioni sono
effettivamente favorevoli ha un senso e aumenta l’autostima, ma fare del
coming out “oggettivamente impossibile” il centro della propria vita
quando mancano le condizioni minime per poterlo affrontare senza grossi
rischi, significa polarizzare tutta la propria vita intorno a un
problema la cui soluzione non dipende da noi e in molti casi è
oggettivamente impossibile. Mi spiego con un esempio. Se un ragazzo vive
in una famiglia difficile, perché conflittuale, quel ragazzo vivrà
indubbiamente una condizione di disagio familiare ma la soluzione del
problema non dipende da lui, farà quindi bene ad assumere un
atteggiamento di distacco e a farsi coinvolgere il meno possibile in
questioni sulle quali può avere solo un’influenza molto relativa. Se
volesse cercare di risolvere comunque il problema andrebbe incontro a
inevitabili frustrazioni. C’è poi un’altra questione fondamentale,
ciascuno è prima di tutto un individuo, poi, eventualmente, è parte di
una coppia o di un gruppo sociale più largo in cui si riconosce. Voglio
dire che se i problemi di tipo sociale devono essere affrontati in
gruppo e quelli di coppia devono essere affrontati in due, quelli
individuali devono essere affrontati e risolti essenzialmente a livello
individuale e non devono essere trasferiti in dimensione di coppia o in
dimensione sociale. Fare pesare sulla vita di coppia o sulla vita
sociale i problemi individuali non risolti significa considerare la
coppia o il gruppo come un possibile modo di superare il disagio
individuale, ma questa impostazione è decisamente fragile.
LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA
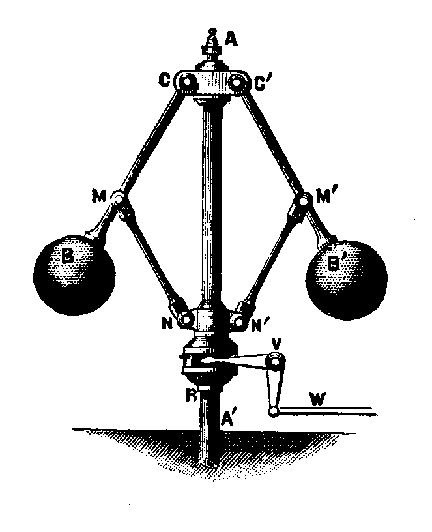
Partiamo
da un esempio fisico, una macchina a vapore priva di meccanismi di
autoregolazione, se alimentata da una corrente di vapore a pressione
progressivamente crescente aumenta progressivamente il numero di giri
dell’albero motore, al limite fino alla rottura della macchina, al
calare della pressione del vapore diminuisce il numero di giri. Questo
significa che il regime di una macchina a vapore priva di meccanismi di
autoregolazione è totalmente dipendente dall’alimentazione. Nel 1782
James Watt brevettò il regolatore di Watt, un meccanismo collegato
all’albero motore di una macchina a vapore che, all’aumentare del numero
di giri, modificando la propria geometria per effetto della forza
centrifuga, provvedeva a chiudere progressivamente la valvola di accesso
del vapore, in questo modo il regime della macchina a valore poteva
rimanere costante anche in caso di aumento della pressione di
alimentazione.
Che
cos’è l’autonomia? È la possibilità di autoregolarsi anche in casi di
sovraesposizione o di aumento di stimoli esterni. Anche il cervello ha
bisogno di meccanismi di autoregolazione che impediscano che la
sovreccitazione possa portare a condizioni di stress pericoloso. Sono
esempi classici di meccanismi di autoregolazione quelli legati
all’abitudine che abbassa i livelli di coinvolgimento e quelli relativi
all’applicazione di filtri o di tempi di ritardo prima della risposta.
Una vera autonomia si raggiunge quando una persona è capace di regolarsi
da sé per mantenere un equilibrio interiore tra le varie componenti
affettive, volontarie e razionali della sua personalità. Come si
acquisisce l’autonomia? La risposta è necessariamente articolata. Come
in tutti i comportamenti umani esiste una base solida di tipo genetico
sulla quale si inserisce un lungo processo di apprendimento di
comportamenti. Come si impara ad amare, così si impara ad essere
autonomi vedendo degli esempi, prima di tutto in ambiente familiare e
poi anche in altri ambienti. Chi vive in famiglie e in società
fortemente gerarchizzate e con un senso della gerarchia molto
interiorizzato, difficilmente tende a sviluppare una vera autonomia di
comportamento, per quelle persone l’omologazione è un valore e l’essere
accettati in famiglia o in società è il giusto premio di quella
omologazione, in quei casi raggiungere una vera autonomia è un processo
difficile da sviluppare contro-corrente. L’autonomia non è
l’indipendenza da un ambiente ma la capacità di autoregolarsi che è il
presupposto per potersi allontanare da qualsiasi ambiente. Allontanarsi
non significa andarsene via fisicamente ma rendersi indipendenti. Come
accade che uno stato, per rendersi indipendente da un altro, debba
sviluppare un suo proprio sistema di regole, così accade anche per le
persone: l’autonomia, cioè l’autoregolazione, in pratica la capacità di
darsi delle regole che permettano la conservazione dell’indipendenza nel
tempo, è la condizione per creare una vita adulta indipendente. Chi
scappa da un ambiente ma non è autonomo perché incapace di darsi delle
regole che permettano il mantenimento della situazione di indipendenza
prima o poi finirà in nuove situazioni di dipendenza.
Esistono
alcune regole fondamentali che permettono il mantenimento di un
autonomo equilibrio personale. La prima di queste regole consiste nel
non trascurare nessuno degli aspetti della propria personalità e nel non
farsi travolgere dagli eventi. L’esperienza è maestra di autonomia, in
particolare l’esperienza ripetuta della frustrazione e della delusione
porta nella dimensione dell’usuale eventi che quando accadono per la
prima volta hanno un alto potenziale dirompente. In altre parole
l’esperienza insegna ad essere autonomi controllando e riducendo il
senso dei delusione e di frustrazione. Un vero scoglio nella conquista
dell’autonomia è dato dalla difficoltà di auto-valutarsi che ha come
conseguenze la sopravalutazione o la sottovalutazione di sé in diversi
campi e la conseguente errata valutazione degli obiettivi in rapporto
alla reale possibilità di conseguirli. L’autostima cresce attraverso un
meccanismo di determinazione di obiettivi, di impegno per raggiungerli e
di effettivo conseguimento di quegli obiettivi. Se l’obiettivo è fuori
portata, cioè è scelto senza tenere conto delle proprie possibilità, il
risultato finale non sarà un aumento ma una diminuzione dell’autostima.
L’esito
più comune della mancanza di autonomia è il vittimismo, purtroppo
piuttosto diffuso tra i gay. Il vittimismo da radici oggettive e solide,
cioè è spiegabile sulla base di forme di disagio molto concrete ma
resta in ogni caso un atteggiamento mentale diametralmente opposto alla
vera autonomia. L’atteggiamento vittimistico cerca consolatori, cioè
persone che favoriscano e confermino quell’atteggiamento. Nella
dimensione vittimistica ogni tipo di impegno della volontà è inutile, le
colpe sono integralmente scaricate all’eterno e tutti i ragionamenti
conducono inevitabilmente al fatto che “tanto” non c’è nulla da fare.
Contro questo atteggiamento esistono varie possibilità di intervento,
prima di tutto la socializzazione in un ambiente non votato al
vittimismo, possibilmente con degli obiettivi concreti a breve termine
che richiedano un impegno immediato e impediscano l’infinito bla bla
inconcludente che spesso accompagna il vittimismo. In secondo luogo,
alle persone con atteggiamenti vittimistici non bisogna fornire una
spalla su cui piangere ma delle alternative concrete, un fare in luogo
di un parlare, una fare concreto che abbia un inizio e una fine e che
produca dei risultati visibili. Non dimentichiamoci mai che dietro
questi atteggiamenti ci possono essere forme di sofferenza profonda,
quindi nessun atteggiamento di contrapposizione o di polemica, nessun
tentativo di convincere in astratto la persona portatrice di
atteggiamenti vittimistici ad accettare altre visioni della vita.
Sottolineo che spesso il vittimismo è legato alla netta
sopravvalutazione dei livello di soddisfazione altrui e a una netta
sottovalutazione del peso della volontà nella costruzione
dell’autostima, il confronto con la realtà è quindi essenziale per
riportare le valutazioni entro termini realistici.
Il
disagio gay esiste ma esistono anche molte vie per superarlo o per
imparare a conviverci, in ogni caso però resta essenziale la componente
dell’impegno volontario e serio per cambiare le cose.
__________
Se volete, potete partecipare alla discussione di questo post aperta sul Forum di Progetto Gay:
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento